TEATRO TEATRALE E ATTORE VIRTUOSO
di
GIAN PIETRO CALASSO
IL PONTE
rivista di dibattito politico e culturale fondata da Piero Calamandrei
Anno XLII, N.6, novembre, dicembre 1986
Il 9 e il 10 settembre, a Roma, a Villa Medici, la compagnia giapponese En, in tournée europea, ha proposto al pubblico italiano due repliche di una propria interpretazione della Fedra di Racine. Per quanto solo un ristretto numero d’invitati abbia potuto assistere allo spettacolo, e al di là del valore della messa in scena di per sé, l’occasione si presta a sollevare problemi e stimolare riflessioni di portata e interesse più vasti.
Nel panorama del teatro giapponese contemporaneo, lo spettacolo cui abbiamo assistito fa parte del cosiddetto Shìngeki (letteralmente: Teatro nuovo) che comprende la drammaturgia nazionale dalla fine dell’800 a oggi, più tutta quella occidentale di tutti i tempi come, per esempio, la Fedra. Lo Shingeki è, in Giappone, l’esatto equivalente del nostro teatro moderno e contemporaneo, dal quale è stato importato e su cui si è modellato. Ne condivide, quindi, le crisi e i problemi, prima di tutto quello stesso della sopravvivenza al quale, a nostro avviso, oggi, tutti gli altri si riducono e che può riassumersi nel semplice interrogativo: il teatro ha ancora una funzione culturale e sociale che ne motivi resistenza?
Riteniamo che un certo afflusso ai botteghini sia una risposta insufficiente, in quanto determinata da ragioni secondarie e contingenti. Per esempio, un giovane abituato fin da bambino alla televisione, può essere incuriosito da questo spettacolo di cui ha sentito parlare un po’ miticamente, e che deve immaginare come una specie di trasmissione con partecipazione del pubblico in studio. Per le nuove classi, recentemente affacciatesi alla ribalta sociale, andare a teatro rappresenta, prima di tutto, un simbolo di status. Per tutti indifferentemente, per una specie di fenomeno di viscosità culturale, l’antichità di questa espressione tende a creare la suggestione della sua eternità e necessità.
Abbiamo buone ragioni per ritenere, infatti, che le origini del teatro si confondano, nella più remota preistoria, con quelle stesse della cultura e che possa addirittura esser considerato la radice prima di tutte le arti (la pittura, per esempio, sarebbe la successiva differenziazione della sua espressione primordiale: il trucco dell’attore, ecc.). Riteniamo, altresì, che la drammatizzazione corrisponda a una funzione cerebrale innata della specie, come dimostra la tipica forma drammatica di fenomeni primari della vita umana, quali il sogno, il gioco infantile, il rito, ecc.
Ma constatiamo anche che l’avvento della civiltà industriale ha prodotto nuovi mezzi di espressione e soddisfazione della suddetta esigenza psichica di drammatizzazione, quali il cinema e la televisione, competitivi rispetto al teatro, e di fronte a cui, quindi, quest’ultimo appare destinato a forgiarsi una identità insostituibile, o scomparire. All’era millenaria in cui il teatro ha avuto il monopolio della drammatizzazione e che possiamo definire del teatro spettacolo, la selezione culturale lascia dunque solo un’alternativa: l’avvento di quella del teatro teatrale. Definirne esaurientemente la natura è compito che trascende ampiamente lo spazio della presente occasione. Ci limitiamo quindi ad alcune constatazioni elementari.
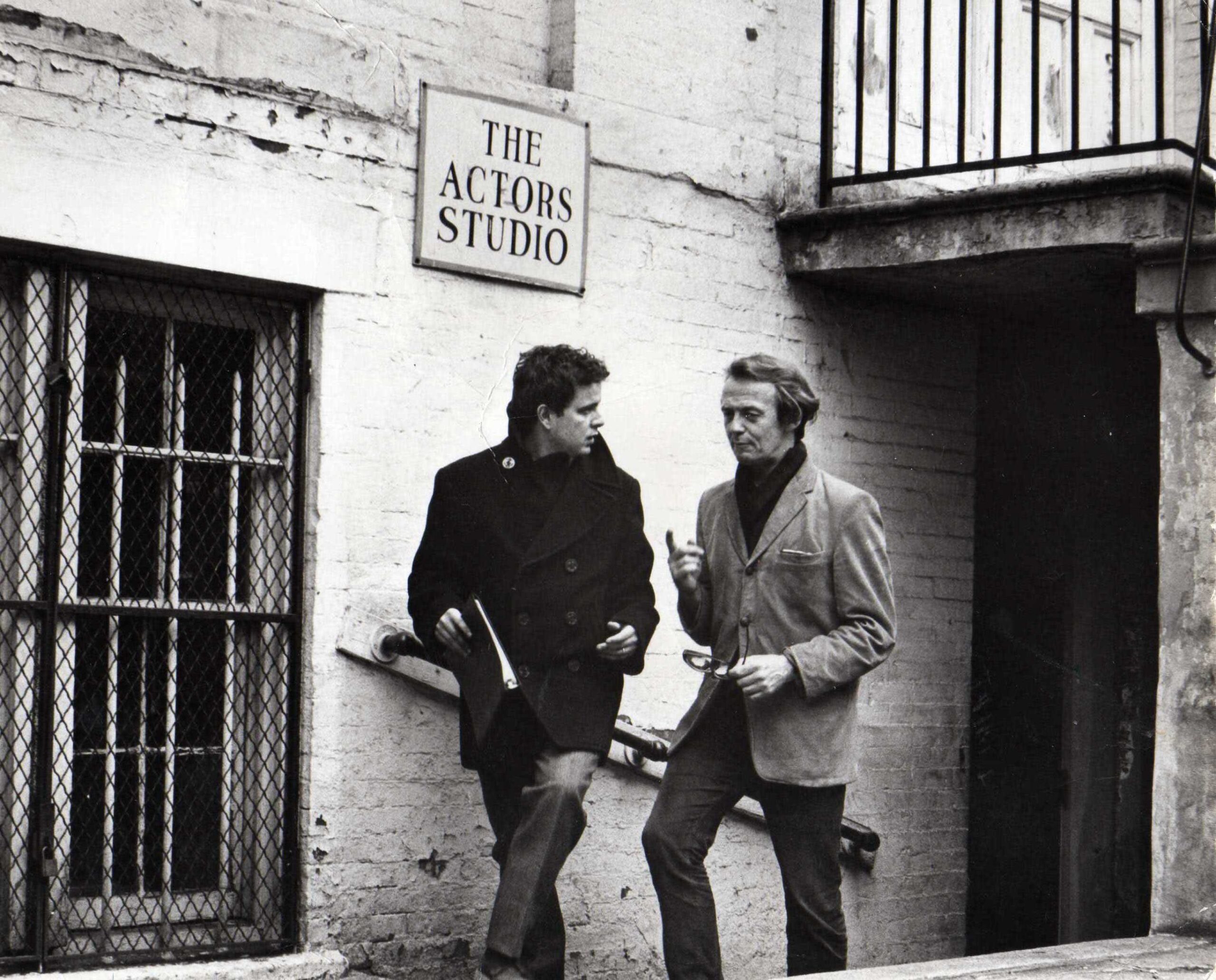
La prima è quella che ad una civiltà di massa deve corrispondere uno spettacolo di massa. Consideriamo, in proposito, il cosiddetto teatro popolare, che alcuni miopi teorici hanno profetizzato e auspicato come quello del futuro. Basta pensare che un edificio teatrale, per quanto grande, può contenere al massimo poche migliaia di spettatori, mentre una trasmissione televisiva può raggiungerne comodamente, nello stesso tempo, molti milioni, per rendersi conto della scarsa adeguatezza del teatro alla suddetta esigenza. In questa costituzionale inferiorità della fruizione teatrale ad opera di un vasto pubblico è implicita, di conseguenza, una mancanza di competitività economica destinata automaticamente ad eliminare, a parità o analogia di gratificazione, il prodotto più costoso o meno remunerativo, nella fattispecie teatro. Inoltre il teatro non è solo meno economico, ma anche, per molti altri versi, meno competitivo. Basta pensare alla superiorità schiacciante del cinema nei campi della credibilità realistica, degli artifici tecnici e degli effetti spettacolari. Per quanto abilmente, per esempio, si possa creare su un palcoscenico la suggestione di una tempesta che sembra vera, sarà sempre realisticamente e spettacolarmente non paragonabile alla analoga resa anche di un semplice artigianato cinematografico standard.
Quanto sopra ci conduce automaticamente all’interrogativo che esprime il nocciolo stesso della questione: è, o può essere, il teatro in grado di offrire una drammatizzazione, per almeno un aspetto essenziale, superiore o almeno irripetibile, che lo identifichi di fronte alle forme di spettacolo con cui si trova in concorrenza m modo sufficiente a motivare la sua sopravvivenza?
Si è, in proposito, insistito soprattutto sulla presenza dell’attore in carne ed ossa, che indubbiamente caratterizza il teatro rispetto alla riproduzione meccanica di cinema e televisione. Ci sembra, tuttavia, che la rilevanza dell’argomento sia stata alquanto inflazionata, e non sufficientemente integrata con altri aspetti, a nostro avviso, di maggiore portata. La sostituzione dell’immagie meccanica alla presenza in carne ed ossa, infatti, è un fenomeno generale che caratterizza numerosi aspetti della civiltà tecnologica, ed è perfettamente funzionale al nuovo contesto storico. La nostalgia del perduto contatto animale deriva piuttosto dal residuo di una arcaica, ma superata, consuetudine che non da esigenze insormontabili. Per quanto concerne specificamente lo spettacolo, la presenza del living actor consente indubbiamente un’interazione fra attore e spettatore che va perduta nelle altre forme di drammatizzazione meccanica. Ci sembra, tuttavia, che queste ultime compensino adeguatamente la perdita con altre suggestioni loro proprie ed esclusive. Per esempio, per quanto la partecipazione attiva che il pubblico teatrale trasmette al suo attore sia significante, non dimentichiamo però che l’aspetto fondamentale del rapporto attore-pubblico consiste nel contributo opposto, quello cioè che l’attore fornisce al pubblico. Altrimenti sarebbero gli interpreti a pagare gli spettatori, e non viceversa. Ora, per esempio, la capacità comunicativa di un primo piano e, in genere, il quoziente di credibilità della recitazione cinematografica, sono gratificazioni a priori inaccessibili all’attore teatrale e ampiamente sufficienti a compensare psichicamente lo spettatore della perdita di contatto fisico.
Più rilevanti ci sembrano, quindi, altre considerazioni e differenziazioni. Per esempio, il cinema e, di conseguenza, la televisione, sua estensione derivata ed espressivamente secondaria, sono, per ragioni strutturalmente implicite nel loro stesso mezzo espressivo (la fotografia, caratterizzata dalla perfetta fedeltà di riproduzione della realtà) indissolubilmente legate a una forma di drammatizzazione che possiamo definire genericamente realistica. Avventure e sperimentazioni di tipo alternativo al realismo formano meno dell’uno per cento della produzione e possono, motivatamente, essere considerate l’eccezione che conferma la regola. Diciamo di più: una ipotetica, quanto impensabile, proporzione inversa vanificherebbe a tal punto le capacità tecniche ed espressive e la funzione storica del cinema, da ridurlo a una mera appendice di massa del teatro. Per quanto riguarda quest’ultimo, al contrario, per ragioni altrettanto immanenti alla sua struttura, l’esigenza realistica ha dovuto sempre venire realizzata e soddisfatta tramite una serie di convenzioni, per esempio quella della quarta parete, della compressione spaziale, della verbalizzazione di eventi o fenomeni d’impossibile realizzazione, di una proiezione vocale adeguata all’ambiente, ecc. Imprescindibili esigenze materiali hanno così favorito l’evoluzione di un linguaggio piuttosto evocativo che descrittivo, piuttosto artificiale che naturale, piuttosto simbolico che realistico. Occasionali tentativi storici di invertire queste tendenze, in modo non dissimile dalle evasioni antirealistiche del cinema, hanno piuttosto sottolineato dei limiti che offerto nuove alternative espressive.

Per quanto elementari e sintetiche, le suddette considerazioni sembrano suggerire uno spiraglio sull’identità di teatro e cinema più significante della presenza o meno dell’attore in carne ed ossa.
Ora, soffermandoci un attimo anche solo al limitato ambito dell’interprete, paragoniamo, sia pure nel modo più sommario, la recitazione di un attore, per esempio cinematografico, magari preso dalla strada, con quella di un cantante d’opera. Quanto la gestualità e vocalità dell’attore sono aderenti alla realtà da confondersi praticamente con essa, tanto quelle del cantante sono, al contrario, condizionate da una serie di convenzioni, come, per esempio, di parlare cantando e di essere truccato e gestire in modo adeguatamente visibile ed espressivo in un grande teatro. Altrettanto vale per l’aspetto fisico e la partecipazione psichica. Quanto nell’attore è essenziale l’identità psico-fisica con la natura del personaggio, tanto, nel cantante, lo è la capacità tecnica di evocarlo simbolicamente tramite una serie di artifici, quali l’educazione vocale e la sua aderenza allo spartito. Così il pubblico accetta come normale che il ruolo di un personaggio analogo, per esempio una donna giovane e bella, venga interpretato ora da una attraente adolescente, attrice improvvisata, ora dalla musicalità della voce, virtuosisticamente addestrata, di una obesa donna di mezza età dalla figura e dai lineamenti sfatti. Pur opposte, infatti, entrambe le soluzioni espressive appaiono perfettamente accettabili in quanto motivate e adeguate ai rispettivi contesti drammatici. La loro inversione (l’obesa cantante d’opera di mezza era che recita l’attraente adolescente al cinema, o l’attraente adolescente interprete improvvisata di un’opera lirica) sarebbe non solo tecnicamente impossibile, ma ridicola e grottesca.
Ci auguriamo, con il citato paragone, di essere stati capaci di offrire una prima sommaria, ma emblematica esemplificazione delle diverse identità di cinema e teatro e di quanto potrebbe essere inadeguata la loro confusione, per quanto la consuetudine quotidiana ne offra una casistica meno estrema, ma tutt’altro che rara.
L’eventuale obiezione che l’opera lirica sia una forma di drammatizzazione troppo particolare, per esempio per la sua subordinazione alla musica, per rappresentare adeguatamente tutto il genere teatrale, ci riconduce all’occasione stessa delle presenti considerazioni, la rappresentazione della Fedra ad opera della compagnia En, e alla legittima curiosità del lettore sui rapporti fra questo spettacolo e l’argomento in questione. Per capirlo è necessario riferirsi, prima di tutto, all’humus culturale di cui la suddetta messa in scena è espressione, cioè il contesto complessivo dello spettacolo giapponese contemporaneo e alla situazione unica al mondo che lo rende il banco di prova privilegiato e emblematico di ogni problematica teatrale. Paese pilota della civiltà tecnologica, infatti, il Giappone ha naturalmente sviluppato un cinema e una televisione molto diffusi e evoluti, con cui il teatro si trova a concorrere. Ma il già citato Shingeki, equivalente della nostra prosa, lungi dall’esaurire il panorama teatrale complessivo del paese, ne rappresenta appena un quarto. I restanti tre sono divisi fra altrettante forme classiche: Nō, Kabuki e Bunraku, la cui origine risale, rispettivamente, a più di seicento e trecentocinquanta anni fa. Ora, che il teatro di un paese dell’era industriale possa vantare precedenti classici, più o meno leggendari, non è, di per sé, fenomeno inconsueto. In Italia, per esempio, possiamo citare la Commedia dell’Arte. Quello che è assolutamente eccezionale, invece, è la loro coesistenza. La norma, infatti, è che dove si è sviluppata una forma moderna abbia sostituito, per evoluzione storica, quelle classiche, di cui resta solo un ricordo, più o meno vivo e, magari, nostalgicamente vagheggiato, ma non più attuale e operante. Analogamente, in paesi rimasti a uno stadio evolutivo pre-industriale, forme di drammatizzazione arcaica sopravvivono attivamente, ma in quanto un teatro moderno non ha ancora avuto origine. A proposito del sopra citato esempio della Commedia dell’Arte nel contesto italiano, non debbono trarre in inganno alcune magari celebri e fortunate riesumazioni ad opera di registi contemporanei. Per quanto brillanti e riuscite, si tratta sempre di finzioni intellettualistiche e accademiche, incapaci di far risuscitare un morto, e il loro rapporto con la vera Commedia dell’Arte non è dissimile da quello della mummia di Tutankhamon, nel suo bel sarcofago, con il faraone quando era vivo.
Ben diversa la sopravvivenza, in Giappone, di Nō, Kabuki e Bunraku, frutto di una ininterrotta e spontanea tradizione, tutt’oggi fisiologicamente viva e vitale. Se la grande elaborazione e complessità di tali forme esclude, in questa sede, una descrizione anche sommaria, possiamo sottolinearne, tuttavia, alcuni elementi comuni fondamentali, rilevanti ai fini del presente argomento:
-
Tutte e tre le forme sono profondamente antirealistiche e indissolubilmente legate a convenzioni drammatiche ed estetiche peculiari.
-
Ciascuna implica un virtuosismo tecnico estremamente impegnativo e specializzato.
-
Il loro linguaggio è assolutamente intraducibile in qualsiasi altra forma di drammatizzazione (in particolare cinema e televisione) senza impoverirne o snaturarne sostanzialmente l’essenza.
-
Per quanto originate in epoca largamente pre-industriale, non solo hanno dimostrato capacità di sopravvivenza nella civiltà tecnologica, ma vi occupano tuttora, per unanime e internazionale riconoscimento, un rango di rilievo primario nello scenario del teatro mondiale.
Il complesso di tali caratteristiche concorre in modo univoco a designare le suddette forme di drammatizzazione come espressioni privilegiate di quel teatro teatrale che abbiamo individuato come l’unico adatto a sopravvivere alla concorrenza delle nuove manifestazioni della drammatizzazione, dando vita al singolare paradosso storico che il più autentico teatro del futuro sarebbe quello del passato.

Ma nella stessa vitalità che abbiamo sottolineato si annida il germe dell’estinzione. Totalmente avulso dall’originario contesto storico, il teatro classico giapponese sta probabilmente vivendo la stagione effimera di un fiore nel vaso, ed è destinato, come quello, ad appassire per mancanza di humus e a morire portando con sé il suo segreto, a meno che le sue spore non cadano in un terreno fertile che ne consenta la perpetuazione dei caratteri, seppure tramite rilevanti mutazioni che ne assicurino l’adattamento a un ambiente sensibilmente diverso.
In Giappone tale terreno esiste ed è rappresentato dallo Shingeki. Ma esistono anche le condizioni capaci di produrre le indispensabili quanto complesse mutazioni? Tali interrogativi rendono la tournée della compagnia En l’occasione di una testimonianza di importanza ben superiore a quella di un’epidermica esperienza esotica. Ma, prima di esprimere uno specifico giudizio in proposito, ci sembra opportuno sollevare un’ultima questione teorica: ammesso che l’ibridazione fra passato e futuro sia possibile, quali sono i cromosomi interessati? E quale la natura della mutazione?
Ci sembra che un’analisi degli elementi che concorrono a formare l’essenza del teatro non possa che sboccare in una costellazione di poche costanti e variabili (per esempio lo spazio scenico, il costume, il testo, gli effetti di luce, quelli sonori, il trucco, ecc.) con al centro l’attore, nel ruolo primario e dominante di un sole nel suo sistema e, di conseguenza, che le fondamenta stesse di quello che abbiamo definito teatro teatrale siano da identificare, prima di tutto, con l’avvento di un nuovo e adeguato interprete.
Il tipo di attore della civiltà tecnologica è caratterizzato dalla disponibilità a diverse forme di drammatizzazione, dal teatro al cinema, alla televisione, alla radio, al doppiaggio, ecc. In questo senso possiamo definirlo attore generico e, poiché il común denominatore fra i suddetti mezzi di espressione è quello di una recitazione basata su una identificazione psico-fisica, più credibile e naturale possibile col personaggio, possiamo definirlo anche attore realistico o naturalistico. Ma abbiamo già avuto modo di sottolineare come il realismo sia diventato lo specifico e incontrastato dominio del cinema, e che un teatro fondato sul realismo sarebbe incapace di sopravvivere, per mancanza di competitività. Quanto sopra è più che sufficiente per dedurne che l’attore del teatro teatrale deve essere anti-realistico, ma tale consapevolezza è ancora di gran lunga troppo generica, e ha dato adito a non pochi equivoci. Se il teatro accademico, infatti, continua a offrire una insignificante recitazione che possiamo definire realismo convenzionale, tessuta di vuoti e banali stereotipi che, già nell’800, Stanislavskij aveva giustamente stigmatizzato, quello di avanguardia ha spesso reagito con una violenta alterazione della vocalità e della gestualità che non lasciano, tuttavia, meno insoddisfatti. Il realismo, infatti, ha una sua logica, lontana dall’esaurire tutte le possibilità dell’espressività drammatica, ma provvista di una coerenza che non basta infrangere per offrire una valida alternativa. Così, in mancanza di una motivazione profonda e necessaria, non esitiamo a definire la mera alterazione della vocalità e della gestualità come recitazione immotivata, negando categoricamente non solo che possa rappresentare l’auspicata alternativa del teatro teatrale, ma che abbia un qualsiasi valore, oltre al banale effetto di effimera e superficiale novità.
Ben diverso è il caso della recitazione nei citati esempi spontanei di teatro teatrale. Qui il realismo non è violato gratuitamente, ma per precise esigenze tecniche, estetiche e storiche, che formano sistemi coerenti e rigorosi. E anche degno di nota come questi sistemi alternativi abbiano avuto nel realismo la loro matrice e se ne siano progressivamente emancipati per necessità interiori tanto profonde da essere indipendenti dalla volontà e dalla coscienza. Se il Nō, oggi, appare uno spettacolo elitario, simbolico, cifrato, allusivo ed evocativo e mai descrittivo, dal contenuto fantasmatico, dalla declamazione artificialmente deformata, dalla gestualità rigorosamente stilizzata, non dobbiamo dimenticare, tuttavia, le sue lontane origini di intrattenimento da strada ad opera di saltimbanchi, facilmente accessibile e realisticamente riconoscibile da un pubblico incolto e popolare, e ancora dopo la sua recezione a corte, seicento anni fa, il suo massimo esponente e teorico, Zeami, dava alla monomane (imitazione della realtà) altrettanta importanza che allo yügen, l’ideale estetico cui la drammatizzazione doveva tendere a conformarsi. Analogamente significante l’evoluzione storica dell’onnagata, l’interprete maschile specializzato nelle impersonazioni femminili, diventato il simbolo stesso del Kabuki. Questa complessa e spettacolare forma teatrale nasce all’inizio del XVII secolo dalle danze erotiche di ballerine-prostitute. Per ragioni di buon costume e ordine pubblico, prima alle donne viene interdetto il palcoscenico e i ruoli femminili passano ad adolescenti di aspetto efebico, poi, dato il conseguente incentivo alla pederastia e le risse fra i samurai per contendersi i favori dei giovani attori, anche il Kabuki di efebi viene proibito e l’ impersonazione femminile passa finalmente all’onnagata, l’interprete adulto che rappresenta la donna non più tramite l’analogia realistica della somiglianza fisica, ma solo per mezzo della propria tecnica ed arte e delle relative convenzioni. Analoghe matrici ed esigenze naturalistiche caratterizzano l’evoluzione della marionetta del Bunraku e, paradossalmente, condizionano e determinano i suoi stessi esiti più anti-realistici. Così mentre, da una parte, i testi si sforzavano di rappresentare sempre più fedelmente personaggi e squarci della vita quotidiana, e l’aspetto e la tecnica di manipolazione di imitare nel modo più credibile il comportamento umano, proprio nel realizzare i suddetti fini naturalistici si sono sviluppate e affermate convenzioni, come il doppiaggio a vista del narratore e l’esibizione in scena dell’operatore, che sfidano e contraddicono la stessa esigenza di illusione realistica che ha dato loro origine.

Profondamente diverse fra loro, nate in contesti eterogenei e, anzi, in aperta concorrenza, le suddette forme di teatro presentano, tuttavia, alcune significanti analogie che determinano la loro comune identità teatrale. Per quanto riguarda la recitazione, per esempio, l’analogia più rilevante appare quella di un’estrema specializzazione e complessità tecnica, che implica un addestramento pluridecennale da iniziare nell’infanzia e proseguire praticamente fino alla morte con impegno totale ed esclusivo.
Definiamo tecniche interpretative di questo tipo recitazione virtuosa e identifichiamo nell’attore virtuoso, esattamente agli antipodi di quello generico della civiltà tecnologica e di quello naturalista della drammatizzazione cinematografica, l’unica valida alternativa su cui edificare il teatro teatrale.
Il virtuosismo in questione può esprimersi in stili compieta- mente diversi. Uno shite del Nō, un onnagata del Kabuki, un capo burattinaio del Bunraku, un cantante d’opera, sono tutti interpreti virtuosi a uguale titolo anche se rappresentano il fulcro di espressioni drammatiche altamente differenziate, compieta- mente indipendenti e non interscambiabili. Ma tutte sono accomunate e identificate da un rapporto univoco con la realtà che non è mai di pura imitazione, ma sempre di ricreazione artificiale, cioè traduzione, tramite una tecnica elaborata e complessa, nella nuova dimensione di una convenzione drammatica ed estetica.
E importante sottolineare che il rapporto di questa convenzione con la realtà non è di negazione, ma di traslazione in un sistema formale alternativo che resta profondamente legato alla realtà stessa che ne rappresenta sia la matrice che l’oggetto d’interpretazione. Citiamo, a titolo di esempio, il linguaggio matematico. Le figure geometriche sono astrazioni simboliche prive di riscontro letterale nella realtà, ma dedotte dalla realtà stessa di cui rappresentano non la negazione, ma una versione stilizzata, che ha per scopo di fornirne una interpretazione approfondita.
Ritornando all’ambito specifico della drammatizzazione è opportuno chiarire che non intendiamo svalutare la recitazione realistica e nemmeno impostare un paragone di valore con quella virtuosa. Riteniamo, infatti, che entrambe corrispondano alla stessa funzione mentale di dominio simbolico del mondo oggettivo, caratteristica anche di fenomeni altrettanto primari e paragonabili, come il gioco infantile e l’attività onirica. Vogliamo solo contribuire a stabilire la reciproca identità che le differenzia in modo rilevante nello sviluppo che procede dalla suddetta radice comune. Aggiungiamo ancora che, naturalmente, anche la recitazione realistica può implicare l’uso di tecniche elaborate e complesse, per esempio il metodo Stanislavskij, definibili, in senso lato, come virtuosistiche. La differenza fondamentale, tuttavia, è che il loro impiego non è essenziale alla drammatizzazione realistica, che può avvenire in modo puramente istintivo o, comunque, spontaneo, conseguendo, anzi, così, i migliori risultati (il metodo Stanislavskij), infatti, per esempio, non ha mancato di produrre a sua volta una serie di stereotipi, non dissimili da quei clichés che si è tanto impegnato a combattere). La recitazione virtuosa in senso stretto, quale l’intendiamo, invece, può essere solo il risultato di un apprendimento di grande impegno, in nessun modo sostituibile dalla improvvisazione spontanea anche più ispirata.
Se ci siamo soffermati in particolare sul fenomeno della recitazione è perché abbiamo fondati motivi di identificarla con l’essenza stessa del teatro e, come tale, polo di orientamento anche di tutti gli altri suoi aspetti. Notiamo, en passant, come questo ruolo essenziale rappresenti un ulteriore elemento di identità rispetto al cinema dove, invece, è l’apparato tecnico complessivo ad avere il ruolo dominante, tanto è vero che è possibile fare dell’ottimo cinema anche senza attori, come dimostra il documentario. In teatro, inoltre, se una recitazione realistica è compatibile con una certa stilizzazione degli ulteriori elementi scenici, una virtuosa non lo è con un insieme realistico. L’identificazione del teatro teatrale con l’attore virtuoso, dunque, implica di conseguenza, la stilizzazione di tutta la messa in scena, fenomeno che, in questa sede, ci limitiamo a rilevare, sorvolando su un’analisi particolareggiata in quanto secondaria e complementare all’aspetto primario e essenziale della recitazione.

Nella speranza di avere sinteticamente, ma sufficientemente delineato i problemi teorici fondamentali che l’occasione si prestava a sollevare in modo privilegiato, concludiamo con uno specifico giudizio sulla messa in scena della compagnia En, e sulla capacità dimostrata di averne coscienza e offrirne soluzioni adeguate.
Lo spettacolo è stato presentato nel Gran Salone di Villa Medici, in un allestimento improvvisato con pochi elementi presi a prestito sul posto. Piuttosto che di scenografia, dunque, si può più propriamente parlare di un semplice spazio scenico consistente in una striscia stretta e allungata, traversata da un braccio più corto a formare una croce, delimitata lateralmente da due file di candelabri accesi e, alle estremità, da quattro alti paraventi angolari di stoffa nera, da cui entravano e uscivano di scena gli attori. Nella presentazione giapponese, questo impianto austero era arricchito da qualche concessione in più alla spettacolarità, per esempio il colore rosso vivo e la materia riflettente di cui era composta la pedana adibita all’azione scenica. Evidentemente, tuttavia, il regista ha ritenuto tale maggiore ricchezza visiva un elemento decorativo secondario, di cui poter fare a meno senza compromettere l’essenza dello spettacolo. Un pubblico molto limitato sedeva su tre file di sedie intorno al rettangolo dello spazio scenico. L’illuminazione era altrettanto sobria della scenografia, e consisteva prevalentemente nella diffusa riflessa da un tendone ondulato bianco sotteso al soffitto, su cui erano puntati, dal basso, pochi riflettori fissi. Ogni effetto di luce era assente, eccetto occasionali azzeramenti della diffusa che lasciavano momenti di una penombra punteggiata solo dal tremulo chiarore delle fiammelle dei candelabri, per scandire qualche intervallo dell’azione. Tali momenti venivano accompagnati da musica barocca su nastro, a sua volta unico effetto sonoro oltre a un accento sempre uguale e ripetuto, simile allo sfregare di una spazzola metallica su una stuoia, o a un suono di stoffa lacerata, che occasionalmente sottolineava una battuta o un gesto. Altrettanto sobri i costumi, di gusto monocromatico, con scarse macchie di colore, di materiali e taglio molto semplici, espressione piuttosto di una misurata inventività che di impegno spettacolare o di un rigore storico-filologico, e completati da pochi attrezzi con funzione piuttosto simbolica che di manipolazione realistica. La recitazione era stilizzata, affidata a una declamazione di tipo né quotidiano né psicologico (di volume spesso un po’ alto rispetto all’ambiente) e a una gestualità piuttosto coreografica che naturale. Il cast appariva sufficientemente affiatato e omogeneo. Sia nel contesto dello spettacolo, che nella sua presentazione e successive dichiarazioni in una conferenza stampa ad opera del regista, non sono mancate le citazioni da Nō, Kabuki, e Bunraku, testimonianza della coscienza dei tesori teatrali di cui tali forme di drammatizzazione sono depositarie, e dell’importanza vitale, per lo Shingeki, di ereditarne e perpetuarne i valori. La regia, ad opera di Moriaki Watanabe, anche autore della traduzione giapponese in versi del testo, appariva colta e informata, e proponeva una sua interpretazione della tragedia letta nella chiave teatralmente promettente del fenomeno di possessione.
A questo punto non ci resta che tirare le somme della problematica sollevata dall’occasione di questa messa in scena, espressione del crogiolo teatrale più significativo della civiltà contemporanea, quello giapponese, emblematico luogo geometrico delle esigenze del futuro e delle tuttora vitali soluzioni del passato, domandandoci se lo spettacolo abbia rappresentato una risposta valida e adeguata alle suddette esigenze, riducibile, secondo la nostra diagnosi, al solo interrogativo: «è stata una manifestazione di teatro teatrale».
La destinazione di élite, l’antirealismo, il rifiuto di artifici tecnologici e, in genere, di elementi non competitivi rispetto al cinema, la consapevolezza dell’esigenza di un nuovo linguaggio, quella dei valori teatrali della propria tradizione classica, lo sforzo di raccoglierne l’eredità, sono tutte premesse che sembrerebbero far propendere per il sì.
La nostra risposta, al contrario, è un categorico no.
Per essere veramente concorrenziale nei confronti delle nuove forme di drammatizzazione della civiltà tecnologica, infatti, non basta che il nuovo teatro rinunci all’utilizzazione di mezzi non competitivi, deve anche offrire un’alternativa tanto insostituibile quanto di valore adeguato. Abbiamo identificato tale alternativa nella recitazione virtuosa e nell’attore virtuoso il fulcro essenziale intorno al quale tutto il resto deve gravitare come un sistema coerente e funzionale. Grotowski, per esempio, ha lucidamente teorizzato e realizzato il suo teatro povero, dove scenografia, costumi, illuminazione, effetti sonori, trucco, ecc., sono ridotti a zero, o quasi, ma ricco del virtuosismo dell’attore santo, risultato inimitabile dell’impegno tecnico e della dedizione morale di una vita, e non del mese di prove concesso dal teatro commerciale, né dei due o tre anni di generica preparazione di un’accademia.
I giovani attori giapponesi della Fedra, al contrario, erano volonterosi, diligenti, affiatati, di discreta preparazione generica, ma completamente incapaci di offrire niente di più. Nella presentazione critica dello spettacolo, il regista ha parlato di possessione, paragonata, durante la conferenza stampa, alla «trance». Ma possiamo garantire che nessun attore si è mai avvicinato nemmeno lontanamente a nessuna forma di trance, o niente di simile, a meno di non voler identificare il fenomeno con una sua sbiadita, vuota, insignificante imitazione, il che equivarrebbe allo scambiare un fondo di bicchiere con un brillante. Analogamente si è parlato, per esempio, di «irruzione del sacro nel teatro», ma altrettanto si è trattato di mera retorica di nota origine (Artaud) quanto logora e fallimentare applicazione (i suoi epigoni). Quanto al rivendicato rapporto con Nō, Kabuki e Bunraku, è stato più che altro indicativo della situazione comune a tanti operatori dello Shingeki, come Mida circondati dall’oro, ma incapaci di nutrirsene. Tutto infatti si è limitato a citazioni puramente esteriori, prive di significato così meccanicamente estrapolate dal loro contesto e, soprattutto, completamente svuotate dalla linfa essenziale di un virtuosismo esecutivo, ridotto a semplice, grossolana approssimazione. Così al realismo e allo psicologismo giustamente sospetti, cosa è stato sostituito se non una convenzione improvvisata, oscuramente quanto insufficientemente motivata? La vocalità era innaturale, ma incapace di elevarsi a una dignità musicale. La gestualità stilizzata e simbolica, ma ben lontana dalla espressività e dal rigore della danza. Piuttosto che un’autentica alternativa teatrale, lo spettacolo ci ha offerto un suo modesto surrogato. Piuttosto che una approfondita consapevolezza, una serie di equivoci.
Per non essere fraintesi diciamo pure che questa Fedra di Watanabe e della compagnia En non era priva di pregi, per esempio: sobrietà, semplicità, buon gusto, cultura, impegno, serietà, finezza interpretativa, parziale consapevolezza, ecc. 31 che non toglie che tutto questo sia ampiamente insufficiente ad assicurare la sopravvivenza del teatro, come un cadavere ben composto nella bara non è, per ciò, più vivo.
Siamo convinti, tuttavia, che, se un futuro per il teatro possa esistere, dipenda dalla impostazione e soluzione dei problemi direttamente o indirettamente, esplicitamente o potenzialmente sollevati da un incontro come questo, e siamo grati all’Accademia di Francia e all’Istituto di Cultura Giapponese di averne fornito l’occasione.
Gian Pietro Calasso

